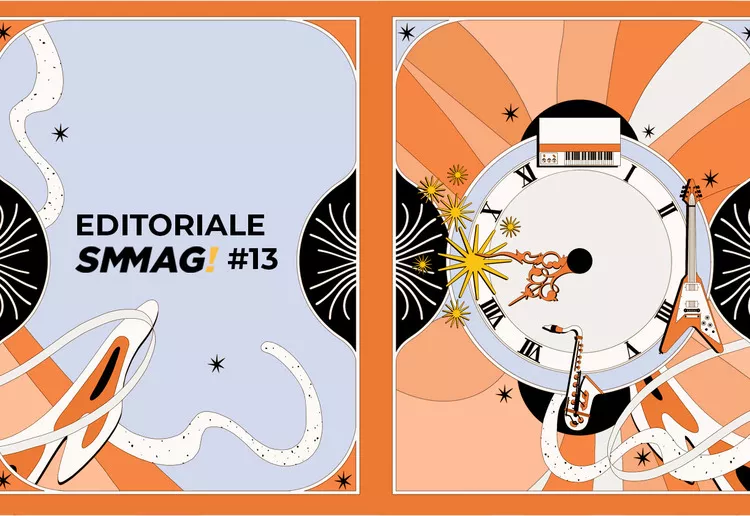Osservatorio
Comfortably Sound: Rifugi Musicali

Martedì 6 febbraio 2024, serata inaugurale del Festival della Canzone Italiana. È l’evento clou del mainstream musicale nel nostro Paese. Sul palco dell’Ariston fanno la loro comparsa, quarti in scaletta, tre ragazzi di 36, 24 e 33 anni. La loro estetica sembra l’incontro definitivo tra la scena punk, il circo Togni e il mondo degli anime. Si fanno chiamare Theø, Plant e Fiks. Insieme, dal 2020, sono La Sad, un moniker che va pronunciato a metà tra l’inglese biascicato e il cörsivœ, la variante allofona dell’italiano inventata e resa virale dalla tiktoker Elisa Esposito.
In MEMORIA, un loro featuring con i bnkr44 del 2023, Plant, il più giovane, altamurano dai capelli blu, canta “poi a 20 anni con due pazzi ho risvegliato il punk”. E, in effetti, anche Autodistruttivo, il brano che presentano a Sanremo è un pop punk al sapore di Blink 182, con una spruzzata di emo wave e suoni trap. Forse il risultato complessivo di questa contaminazione è un depotenziamento del messaggio originale del punk, ma è francamente difficile non ammettere che, tra i pezzi in gara, quello dei La Sad sia il più spigoloso, forse l’unico con un’intenzione davvero rock, graffiata e graffiante.
A fine esibizione, a rafforzare il testo, che parla esplicitamente di depressione e suicidio giovanile, alle spalle del trio vengono mostrati tre cartelloni pesanti come macigni. Sono frasi da vere e proprie “suicide notes”: Alda, 33 anni, afferma “io so solo che non voglio più soffrire”, Andrea, di 18, glissa “non siete voi, sono io”, Giulia a 16 anni confessa “non so perché lo faccio”. Sul retro dei cartelloni, il messaggio di sensibilizzazione del Telefono Amico: “Non parlarne è 1 suicidio”. Si chiude la canzone, parte l’applauso, riappare Amadeus e i tre performer si congedano con un esplicito ringraziamento alla musica per averli salvati.
È il punto di vista di una generazione, quella a cavallo tra gli ultimi millennial e la generazione Z, che sta sdoganando sempre di più il discorso pubblico sulla salute mentale in un’era di reti sociali sempre più effimere, intangibili, a tratti alienanti. Ma non solo. “La musica mi ha salvato” è infatti un messaggio trasversale, che va oltre le generazioni e attraversa tutta la comunità di musicisti e appassionati. È sicuramente un motivo ricorrente, che contribuisce a rendere avvincenti le storie dietro la passione o la creatività musicale. Perché, in fondo, si tratta della parabola, antica almeno quanto la scrittura, dell’eroe che scende agli Inferi per ritrovare la sua strada.
Ma sarebbe davvero triste e limitante credere che tutto si riduca a una semplice questione di narrativa. Basta indagare i motori di ricerca per rendersi conto che non può essere questo il caso. Ci sono quasi 8 milioni e mezzo di risultati indicizzati solo per la query italiana “la musica mi ha salvato la vita”. Sarebbe un’anomalia statistica senza precedenti ammettere che gli autori di quei contenuti siano in gran parte dei bugiardi. Evidentemente, in una frase che tocca le corde di così tante persone, un fondo di verità ci dev’essere.
Ludwig Van Beethoven, parlando della sua arte, sostenne che “La musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza e filosofia. Chi penetra il senso della mia musica potrà liberarsi dalle miserie in cui si trascinano gli altri uomini”. Un’affermazione forte che racchiude in sé la personalità e le convinzioni assolute di un uomo imbevuto di letture illuministe e che, già ai suoi tempi, era riconosciuto come uno tra i più grandi compositori della storia del mondo. Un riconoscimento nobile del potere che la musica ha nell’elevare lo spirito di chi la comprende e vive, offrendo un riparo dagli affanni della vita quotidiana.
E se non sorprende che il titano di Bonn possa aver avuto una tale consapevolezza, è affascinante notare come lo stesso pensiero possa ritrovarsi, seppur in forma diversa, ad anni luce di distanza nel tempo, nello spazio e nell’ambiente sociale. Perché, quando al Newport Folk Festival del 1966, Howlin’ Wolf, presentando Down In The Bottom, racconta “when you ain’t got no money to pay your house rent and you ain’t got no food, then you sure got the Blues”, il bluesman di White Station, Mississippi, non sta solo definendo il suo genere. Sta anche sottolineando il ruolo della musica come unico vero rifugio per chi non ha nient’altro su cui contare.
La biografia di tantissimi artisti di successo ne è la conferma. Pensiamo, ad esempio, a Ray Charles, la cui vita lontano dalle tastiere è stata un continuo susseguirsi di eventi sfortunati o drammatici. A sette anni la perdita della vista per un glaucoma, poi la morte del fratello minore per annegamento, a 14 anni di nuovo in lutto per la madre a cui era legatissimo. Esperienze traumatiche che ha saputo trasformare, grazie alla musica, in energia positiva e creativa, dando vita, ancora prima di compiere 25 anni, a un sound senza tempo, impareggiabile, che abbraccia il gospel, Nat King Cole e le lezioni della strada. La nascita del Rhythm & Blues e di mille altri sottogeneri così come li conosciamo oggi. E ancora, quasi 20 anni dopo I Got A Woman, quando nel 1973 la madre di suo figlio morì di overdose, Ray si rifugiò nuovamente nella musica, rimanendo “pulito” (aveva vinto la sua battaglia contro la dipendenza da eroina nel decennio precedente) e fondando la sua etichetta discografica, la Crossover Records. Così, poté prendere ancora di più le redini del suo processo creativo, tornando in studio e arrivando all’album Renaissance del 1975, con il quale vinse un Grammy per la sua meravigliosa versione soul di Living For The City.
Allontanandoci dalle biografie illustri, il discorso non cambia, anzi diventa ancora più denso di significati. Nelle pieghe più tragiche della storia, la musica ha dimostrato di essere l’ultima risorsa a cui ci si aggrappa per salvarsi. Lo testimoniano, per esempio, le ricerche del maestro Francesco Lotoro, protagonista di un trentennale lavoro di recupero sulla musica concentrazionaria, da lui definita come la “produzione musicale in cattività e, precisamente, in condizioni minime o estreme di privazione dei diritti fondamentali dell’uomo”. Questo pianista e direttore d’orchestra barlettano si è infatti dedicato allo studio, alla revisione, all’esecuzione e alla registrazione di partiture recuperate tra il 1933 (anno dell’apertura del campo di Dachau) e il 1953 (anno di morte di Stalin) in ghetti, campi di concentramento, gulag e campi di prigionia. Più di 8.000 pezzi raccolti e catalogati, tra sinfonie, opere, canzoni folk e gitane, a volte appuntate su materiali di fortuna come telegrammi, carta igienica, incarti alimentari o sacchi di patate. A emergere è la voce disperata ma risoluta di chi ha trovato, anche nel dolore più inimmaginabile, uno spazio sicuro per la propria libertà e umanità, quello musicale appunto.
D’altro canto che la musica giochi un ruolo fondamentale nel percorso individuale e sociale verso il benessere e la salute è ormai un fatto ampiamente dimostrato e accettato. Nel 2021, non a caso a pandemia in corso, l’OMS ha pubblicato il più grande studio sul tema, raccogliendo in un unico report oltre due decenni di ricerche sul contributo che le arti, musica compresa, hanno nella prevenzione e nella promozione della salute, nonché nella gestione e nella cura delle malattie. È davvero straordinario l’apporto che la musicoterapia può fornire nel trattamento delle situazioni e dei quadri clinici più disparati. Solo per fare qualche esempio, studi su larga scala hanno dimostrato i benefici della musica in chirurgia. L’ascolto di musica registrata può abbassare frequenza cardiaca e pressione arteriosa nel preoperatorio, con prove che suggeriscono anche una maggiore efficacia rispetto ai farmaci utilizzati per questo scopo. Dopo gli interventi, la musica si è dimostrata efficace nel ridurre ansia, dolore e, di conseguenza, il bisogno di ricorrere ad antidolorifici.
Studi dimostrano inoltre che la musica aiuta, per esempio, chi è colpito da ictus a sviluppare nuovi percorsi neuronali, con miglioramenti nel recupero della memoria verbale e della capacità di concentrarsi, riduzione della depressione e della confusione, maggior rilassamento e progressi nell’attività motoria. Ascoltare, suonare e cantare possono portare grandi benefici nella vita dei malati di Alzheimer, aiutandoli a migliorare le condizioni delle proprie capacità cognitive fondamentali, comprese attenzione e memoria a lungo termine.
Per i pazienti oncologici, sia adulti che bambini, la musica è tra i migliori compagni di terapia possibili: molti studi infatti dimostrano che l’ascolto può alleviare effetti collaterali come sonnolenza, inappetenza, affanno e nausea, riducendo così il bisogno di antiemetici (farmaci contro il vomito) e alleviando depressione e fatica, a tutto vantaggio di un senso di ritrovata vitalità.
Se ci spostiamo a scuola, la musica è oggi una risorsa preziosissima nella didattica inclusiva per gli studenti B.E.S (Bisogni Educativi Speciali), un gruppo che include bambini e ragazzi con disabilità riconosciute dalla legge 104, chi è da poco arrivato in Italia senza conoscere la lingua, chi ha alle spalle delle situazioni familiari complicate, nonché gli alunni affetti dai DES, ovvero disturbi evolutivi specifici, e DSA, disturbi specifici dell’apprendimento, come dislessia, disortografia, discalculia. La musica funge da valvola di sfogo per i bambini o ragazzi impulsivi, coadiuva lo sviluppo cognitivo aiutando ad affinare prestazioni e strategie socio-emotive, coinvolge e favorisce l’integrazione fisica, psicologica e sociale degli studenti B.E.S. nell’ambiente classe.
Il lavoro svolto quotidianamente a scuola da insegnanti di sostegno ed educatori parla di veri e propri successi della musicoterapia nel contenere e soprattutto migliorare i comportamenti legati alla disattenzione, all’impulsività e all’iperattività, portando gli studenti a convogliare le proprie energie in modo funzionale, con un incremento dei tempi di attenzione e della capacità dell’ascolto.
Se il mondo della ristorazione e gli chef ci hanno insegnato negli ultimi anni a riscoprire ed esaltare il valore del “comfort food”, ovvero del cibo che dona conforto all’anima, oggi dovrebbe essere naturale parlare anche di comfort music in tutti i contesti in cui la musica può avere un impatto: a scuola e nelle strutture ospedaliere, ma anche nelle carceri, nei campus universitari, nei centri di accoglienza, negli spazi pubblici e anche in quelli privati. Perché nel saldo dare-avere, la musica risulta sempre essere una delle più generose espressioni dell’uomo. E se, in Comfortably Numb, i Pink Floyd ricordavano le sensazioni vissute da Roger Waters dopo un’iniezione anti-epatite a cui era stato costretto a sottoporsi prima di un live a Philadelphia nel ‘77, tutti noi davanti a canzoni come quella e a centinaia di altre possiamo sentirci “comfortably sound”, al sicuro tra le braccia della musica.
![Il Sabato di [UNVRS] è Marchiato Elrow](https://staticn.strumenti.net/750/2025/11/18/e7/sabato-unvrs-marchiato-elrow-mobile.webp)